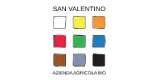Dal 15 al 17 novembre Bologna torna a essere la capitale del vino indipendente. Mille vignaioli da ogni regione d’Italia, tre delegazioni europee appartenenti alla CEVI e ventotto soci della FIOI – i produttori di olio indipendente – si riuniranno per il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti FIVI, la quattordicesima edizione di un evento che, più che una fiera, è una dichiarazione di identità.
Chi attraversa i padiglioni di BolognaFiere trova produttori che versano il vino con le proprie mani. È una scena semplice, quasi antica, eppure pienamente contemporanea. In un mercato che cambia – tra dazi americani, trattative europee e tensioni economiche – il Mercato FIVI diventa una risposta culturale: riportare il vino alla sua voce originaria.
Una geografia completa del vino artigiano, capace di unire agricoltura, cultura e autonomia produttiva. L’obiettivo è restare fedeli al principio fondativo della FIVI: il vignaiolo come custode integrale del ciclo produttivo – dalla vigna alla bottiglia – e come ambasciatore del territorio. Qui il vino non è solo un prodotto, ma una narrazione: di paesaggi, generazioni, mani.
Chi entra al Mercato dei Vini lo capisce subito: non si viene solo a degustare, ma a dialogare. Ogni banco è un piccolo racconto, ogni bottiglia un’idea di mondo. L’atto di vendere direttamente, senza intermediari e senza filtri, assume il valore di un gesto politico e culturale. Dietro a un calice di Sangiovese, Nebbiolo o Fiano ci sono scelte che riguardano l’acqua, il suolo, il clima, il tempo. E forse è proprio questa la ragione del suo successo: il bisogno crescente, da parte del consumatore, di dare un volto a ciò che beve. In un’epoca di algoritmi social, corse senza senso ai like e listini automatizzati, il vino indipendente restituisce un senso di realtà, un contatto fisico con l’origine: si presenta com’è , “nudo”, diretto, sincero, solo con la forza del lavoro e del tempo.
Ogni edizione del Mercato FIVI è anche un laboratorio di domande. Come può il piccolo produttore affrontare l’incertezza dei mercati globali? È sostenibile un modello che vive soprattutto di vendita diretta? E ancora, come si concilia la tutela del paesaggio con l’esigenza di crescere e innovare? La sfida climatica impone scelte agronomiche nuove: portainnesti resistenti, vitigni autoctoni recuperati, pratiche rigenerative. Il vignaiolo indipendente diventa così anche un osservatore del cambiamento, un guardiano del territorio che sperimenta ogni giorno sulla propria pelle gli effetti del clima che muta. Ma la domanda più interessante, forse, è un’altra: quanto conta oggi la libertà di un produttore? In un tempo in cui tutto tende alla standardizzazione, il valore dell’indipendenza non è solo economico: è culturale.
L’edizione 2025 guarda anche oltre i confini italiani. Le delegazioni CEVI, provenienti da Francia, Spagna e Austria, portano un messaggio di coesione: il vignaiolo indipendente europeo vuole contare di più nei tavoli decisionali dell’Unione, chiedendo regole che tutelino chi produce in piccola scala ma con alto valore aggiunto. Il legame con i produttori di olio FIOI arricchisce questa visione. Vino e olio diventano due linguaggi dello stesso territorio: agricolture “sorelle” che condividono la necessità di autenticità, tracciabilità e rapporto diretto con il consumatore.
In un momento storico in cui i dazi USA e le trattative con Mercosur e India possono ridefinire gli equilibri commerciali del vino europeo, iniziative come quella di Bologna assumono un significato più ampio: quello di una diplomazia dal basso, fondata su relazioni umane e fiducia reciproca. C’è qualcosa di profondamente italiano in tutto questo. Il nostro Paese non ha mai avuto un modello unico di produzione, ma una costellazione di storie, dialetti, tecniche e filosofie. Ogni vignaiolo indipendente porta con sé una lingua, un ritmo, un paesaggio. Insieme formano la trama di un mosaico fragile ma luminoso, che resiste perché sa adattarsi.
Il Mercato FIVI è la rappresentazione più fedele di questa complessità: un luogo dove un piccolo produttore dell’Etna può confrontarsi con chi lavora in Valtellina, dove si scoprono affinità inattese tra un vitigno di montagna e uno mediterraneo. È qui che il vino torna a essere un atto culturale, una lente attraverso cui guardare l’Italia e le sue trasformazioni.
Alla fine, il Mercato FIVI non si misura solo in bottiglie vendute o in etichette scoperte. Si misura nel tempo dedicato a una conversazione, nel racconto di un’annata difficile, nella stretta di mano tra chi produce e chi beve. È un luogo dove il vino smette di essere marketing e torna a essere relazione. E forse è questa la sua lezione più grande: ricordarci che bere bene non significa solo scegliere una buona bottiglia, ma condividere una visione del mondo. Tra le file di BolognaFiere, tra accenti, dialetti e calici che si toccano, il vino italiano racconta di nuovo se stesso – indipendente, fragile, resistente. E soprattutto, vivo.
FIVI 2025, L’ITALIA DEI VIGNAIOLI SI RITROVA A BOLOGNA