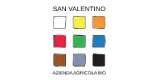A Belém, in Brasile, si è aperta la COP30, il vertice ONU sul clima. È il primo ospitato in Amazzonia, e già si annuncia come uno dei più politici degli ultimi anni. “È il momento di sconfiggere i negazionisti”, ha dichiarato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, padrone di casa e nuovo volto di un ambientalismo che prova a essere anche sociale.
Ma i negoziati di Belém cominciano con un’assenza pesante: per la prima volta gli Stati Uniti si sono sfilati del tutto dai colloqui. Donald Trump, tornato alla Casa Bianca, ha bollato la crisi climatica come “una truffa” e rilanciato un’agenda pro–fossili. “Meglio nessun coinvolgimento che un sabotaggio”, ha commentato un diplomatico europeo, ricordando come Washington abbia ostacolato, nei mesi scorsi, la proposta di una tassa sulle emissioni del trasporto marittimo.
Un’assenza che pesa: gli USA restano il secondo emettitore mondiale di gas serra, dopo la Cina, che invece consolida il proprio ruolo di guida della transizione, con nuovi piani per ridurre le emissioni del 7–10% entro il 2035. Xi Jinping non è a Belém, ma Pechino si fa sentire: oltre la metà dell’energia elettrica cinese è già rinnovabile, e metà delle nuove auto vendute sono elettriche.
Nel frattempo, l’Unione Europea, presente ma indebolita da rallentamenti nella transizione verde e da tensioni politiche interne, prova a difendere la propria leadership climatica anche sul piano agricolo. È in questo contesto che, pochi giorni prima dell’apertura della COP, la FIVI – la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti – ha presentato a Bruxelles, insieme alla CEVI, un documento che chiede una politica europea capace di sostenere chi lavora la terra in modo diretto e sostenibile: meno burocrazia, più accesso ai fondi del Green Deal, e un riconoscimento pieno del valore culturale e ambientale del vignaiolo.
Due eventi lontani solo in apparenza: la COP che discute il futuro del pianeta e i vignaioli che, ogni giorno, lo vivono nel concreto. Perché la transizione ecologica, nei filari, non è un principio astratto: è decidere se arare o inerbire, se irrigare o resistere, se perdere un raccolto per salvare un equilibrio.
In Italia, il 2025 fotografa un momento di passaggio. Le esportazioni di vino segnano un lieve calo, intorno al –3,4% in volume, ma dietro i numeri si nasconde un cambio di paradigma. Cresce la ricerca di autenticità, di coerenza, di senso. Non basta più un’etichetta bella o un post virale. Il consumatore chiede un racconto vero — e chi lo offre è chi non rincorre i trend, ma la propria verità. Ecco perché la voce dei vignaioli FIVI è più attuale che mai.
La COP30 parla di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni, ma i vignaioli conoscono la crisi climatica da vicino: l’hanno vista cambiare le fioriture, anticipare le vendemmie, modificare i profumi del vino. E mentre le grandi potenze si contendono il ruolo di guida, nelle vigne italiane si costruisce — silenziosamente — un modello di adattamento. Perché il vino, in fondo, è un indicatore del mondo: reagisce al calore, all’acqua, alla fretta. Ci dice quanto il clima stia cambiando, ma anche quanto l’uomo possa cambiare con lui.
Il messaggio che arriva da Bruxelles e da Belém, letto insieme, è chiaro: la sostenibilità non è più un’opzione. È una forma di sopravvivenza culturale. E in questo senso, i vignaioli indipendenti hanno qualcosa da insegnare anche alla politica: che la coerenza, come il vino vero, non si improvvisa. Si coltiva.
DAL VERTICE ONU IN BRASILE ALLE VIGNE ITALIANE: IL CLIMA DIVIDE LA POLITICA, MA UNISCE I VIGNAIOLI