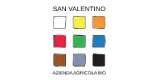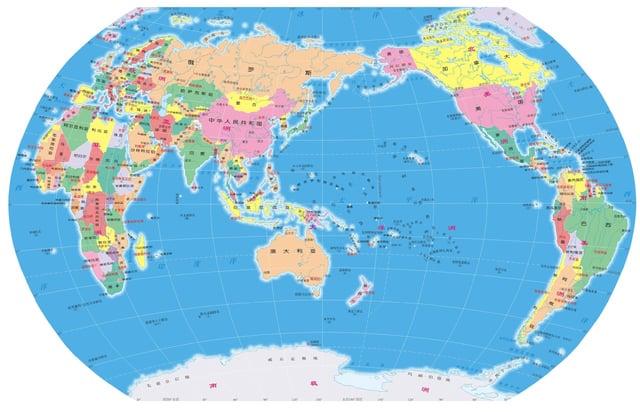Il 2025 è stato un anno di segnali contrastanti per l’export enologico italiano: sul dato aggregato pesano dinamiche macro — da una modesta flessione dei volumi a segnali di consolidamento del valore — mentre sul piano geopolitico e tariffario le incertezze rimodellano i percorsi commerciali. In questo contesto, il 2026 presenta opportunità concrete nei mercati asiatici del Sud-Est e in alcune piazze latino-americane, a condizione che imprese e consorzi sappiano giocare tre carte decisive: presidio normativo (proteggere il valore del marchio), capacità di posizionamento premium e adattamento logistico-commerciale.
Il Brasile e l’area Mercosur rappresentano una finestra che si è riaperta. Dopo anni in cui i dazi elevati hanno penalizzato il vino europeo, l’accordo auspicato tra Unione Europea e Mercosur — che prevede la progressiva riduzione delle tariffe su prodotti come il vino — può ridurre un ostacolo strutturale e rendere il Brasile un bersaglio reale per i produttori italiani, soprattutto per i segmenti premium e per le denominazioni con forte identità territoriale. È una dinamica che il settore segue con attenzione: dai margini di ritorno alle modalità distributive, il ritorno su scala richiederà investimenti in trade marketing e catene del freddo, ma la leva tariffaria, se confermata, cambia le condizioni di competitività.
L’Asia sud-orientale resta un terreno di crescita strutturale, benché non privo di ostacoli. Corea del Sud, Vietnam e Indonesia mostrano trend di consumo in ascesa per il vino importato, trainati da crescita dei redditi, espansione della ristorazione e un’offerta retail sempre più sofisticata. Tuttavia, le politiche fiscali e regolatorie possono cambiare rapidamente: il caso del Vietnam — dove è stata approvata una progressiva stretta fiscale sulle bevande alcoliche — ricorda che l’attrattiva di un mercato deve essere misurata anche in funzione del rischio regolatorio. Per l’Italia la strategia vincente è segmentare l’offerta: vini accessibili per la grande distribuzione urbana, proposte territoriali premium per ristoranti e canali Horeca, e attività educational per formare una domanda consapevole.
L’Indonesia, pur partendo da numeri relativi (le importazioni rimangono modeste rispetto a mercati storici), mostra un tasso di crescita sostenuto, con proiezioni che indicano espansione dei volumi importati nei prossimi anni. Per gli esportatori italiani questo significa sperimentare formati, selezioni SKU mirate e partnership sul territorio per aggirare barriere logistiche e doganali. È un mercato che premia la strategia di lungo periodo: presenza di marca, formazione dei canali e adattamento del pricing.
Gli Stati Uniti restano – nonostante tensioni tariffarie e un mercato sempre più selettivo – un mercato chiave per il vino italiano, ma con dinamiche mutate: la domanda si polarizza, la “premiumisation” avanza e i margini diventano più legati alla capacità di posizionamento che al volume. L’introduzione di dazi aggiuntivi e l’aumento dei costi logistici e distributivi rendono il mercato statunitense più costoso e selettivo; tuttavia, per quei produttori in grado di presidiare il canale on-trade e i segmenti premium, gli USA restano essenziali per immagine e fatturato. La parola d’ordine qui è “targeting”: non più presenza generalista, ma presenza mirata.
Quali implicazioni operative per le aziende italiane? Primo: investire in protezione del marchio e capacità contrattuale (distributori, contratti logistici, gestione delle dogane). Secondo: calibrare il portafoglio prodotti in funzione del mercato — SKU snelli e storie territoriali per i canali Horeca, linee entry-price per i retailer in aree ad alto potenziale. Terzo: rafforzare l’attività di formazione e comunicazione sul posto — masterclass, eventi e campagne che raccontino terroir e persone, non solo tecnicismi, perché il consumatore emergente compra storie tanto quanto qualità.
Infine, un richiamo alle grandi variabili: la produzione mondiale mostra segni di recupero dopo il 2024 (con la stima OIV su 2025 in aumento rispetto al minimo dell’anno precedente), ma la dinamica dell’offerta non cancellarà le pressioni sui prezzi e sui canali. Ne consegue che il successo sui mercati nel 2026 non sarà né automatico né uniforme: dipenderà dalla capacità delle imprese italiane di leggere le specificità locali, di proteggere i marchi e di investire in posizionamento strategico.