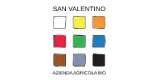“L’agricoltura si basa su un binomio fortissimo prodotto e territorio che vale anche nel turismo. C’è una sinergia strutturale tra i due settori”, spiega al convegno sullo stato di salute dell’enoturismo, organizzato a Recanati dall’Istituto marchigiano tutela vini (Imt), Cristina Mottironi della Bocconi School of management, che dalla prima ora ha studiato la capacità turistica applicata al vino. “In Italia si è iniziato a legiferare e a sviluppare il turismo enogastronomico negli anni ’90 con finalità diverse da quelle di oggi. Allora, dopo lo scandalo del metanolo, il tema era affrancare la domanda e si utilizzava il turismo per riavvicinare le persone al vino. Le leggi di oggi hanno una finalità diversa, vanno a lavorare sulla filiera per crearne una più competitiva e in grado di rispondere a una domanda che a sua volta sta cambiando e da cui bisogna partire perché è la domanda che guida le scelte. Ragioniamo sul turismo con l’idea di attrarre visitatori nei nostri territori, nelle nostre aziende”.
Ma qual è il vero valore del turismo enogastronomico in una bulimia di dati che non rende semplice quantificare il fenomeno? “Il primissimo elemento che dobbiamo prendere in considerazione è che oggi non parliamo più di un turismo di nicchia ma nemmeno, fortunatamente, di un turismo di massa. Si stima che le persone che si muovono con una motivazione primariamente enogastronomica siano 10-15 milioni, una decina di anni fa erano 5 milioni. In realtà è un turismo molto più trasversale oggi, perché il turista balneare o mosso dal dato culturale o sportivo ha poi un interesse a conoscere le tradizioni enogastronomiche di un territorio. Un terzo della spesa turistica complessiva, circa trenta miliardi per il nostro paese, sono destinati al vino e al cibo, una voce di spesa importante su cui fare leva. Ormai è un turismo non più solo locale ma internazionale. I dati della Banca d’Italia confermano che la spesa per l’enogastronomia dei turisti stranieri è seconda solo a quella legata a prodotti inerenti esperienze di arte e cultura. Per mercati internazionali ci si riferisce a quelli target per il turismo nel nostro paese, quindi Stati Uniti, Germania, Francia, Inghilterra, che sono anche i paesi in cui esportiamo di più. I dati più recenti, inoltre, ci confermano che i turisti cinesi hanno un interesse crescente per l’enogastronomia italiana”. Continua Cristina Mottironi: “Il turismo enogastronomico ha una ricaduta economica importante: si stima che circa il 60% dei turisti che visitano i luoghi di produzione, come le cantine, spendano più di 50 euro per ogni visita con una ricaduta ancora più ampia sulla filiera territoriale, per una spesa giornaliera di circa 140 euro. Vacanze brevi ma con una spesa pro capite rilevante, un dato che si trasforma per le aziende, in particolare vitivinicole, in un contributo al fatturato intorno al 7% per le aziende più grandi e al 14% per quelle più piccole e che nei territori più vocati e sviluppati arriva fino al 30%”. Affonda: “Il valore non risiede però solo in questo: al turista che fa esperienza diretta possiamo trasferirgli quei valori identitari che caratterizzano le nostre produzioni. Il focus vero è creare valore economico sui nostri valori identitari. Solo così riusciamo a trasferire le caratteristiche di qualità, sostenibilità, artigianalità che caratterizzano le produzioni, aspetti difficili da veicolare a distanza o solo attraverso la distribuzione, consolidando l’immagine dell’azienda. É un valore, quello del turismo enogastronomico, che va al di là della sola spesa turistica. Attenzione, però, perché oggi il turista sta cambiando, la domanda sta diventando sempre più sofisticata, competente. L’offerta enogastronomica si sta omologando troppo. Bisogna lavorare per diversificare quello che offriamo a chi non cerca esperienze standardizzate. Il brand Marche inizia a crescere, forte nel suo insieme, ma c’è uno spazio di lavoro ancora importante da realizzare in sintonia con il livello regionale perché si registra una minor conoscenza sul mercato delle produzioni. Abbiamo una legge di supporto, ma soprattutto c’è una logica di sistema da portare avanti. Nel turismo nessuno può ragionare da solo. Il turismo non si può sviluppare con un solo contributo. Bisogna riuscire a lavorare con una logica di filiera e una sinergia tra pubblico e privato, su una immagine e una comunicazione convincente per il mercato turistico. L’esperienza enogastronomica va distribuita sui canali più adeguati. C’è la necessità di presidiare la qualità e la sostenibilità del territorio”. Conclude: “Sono assolutamente d’accordo che il turismo enogastronomico debba restare una competenza dell’agricoltura, perché il presidio dei valori di qualità e di sostenibilità del territorio vengono da lì, ma c’è anche una contaminazione o meglio una fertilizzazione importante nel momento in cui si lavora insieme e si crea un territorio specializzato in un tipo di offerta. Quindi l’attenzione che le Marche hanno per il piccolo, per la qualità, per la sostenibilità, in particolar modo nel mondo agricolo, può diventare un valore enorme anche per chi fa turismo. Serve formazione, perché turismo enogastronomico significa che il mondo dell’agricoltura deve diventare imprenditoriale anche sul lato turistico e il mondo del turismo deve diventare imprenditoriale anche su quello dell’enogastronomia. I primi devono capire cosa significhi fare accoglienza in cantina, utilizzare strumenti digitali, creare esperienze, offrire servizi al turista e chi offre servizi turistici deve essere veicolo di promozione dei prodotti del territorio, cosa che spesso manca agli operatori, che spesso non conoscono e quindi non promuovono le identità locali. Solo ragionando in un’ottica di filiera siamo in grado di attirare economie di sistema fondamentali”.
BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT: CREARE VALORE ECONOMICO SUI VALORI IDENTITARI