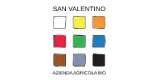Cantine in città, alle Artificerie Almagià a Ravenna, sabato scorso ha registrato un pubblico di appassionati che come i vini in degustazione era di alto livello. A pensarci bene non c’è da stupirsi più di tanto. Condivido con voi qualche riflessione perché mi è venuto in mente un libro che ho recensito di recente, Il richiamo della montagna, di Matteo Righetto, dove l’autore dice una cosa vera: è l’ospitante che dà la forma all’ospite. In pratica, attiriamo ciò che siamo e, aggiungo, siamo ciò che mangiamo (e beviamo). E Ravenna città d’arte e cultura, con i suoi otto monumenti Unesco, con il più ricco patrimonio mondiale di mosaici databili fra il V e il Vi secolo d.C. custoditi all’interno dei suoi edifici paleocristiani e bizantini, che ospita la tomba del Sommo Poeta nella zona dantesca, con quel suo essere un po’ fuori dalle rotte stradali più comode, attira un turista esigente. Il turista medio Unesco, richiamato dal valore culturale offerto dal prestigioso riconoscimento, risponde a un profilo internazionale educato, consapevole e rispettoso dell’ambiente. È il turista non Unesco che contribuisce all’assalto incivile. Il turista Unesco non si accontenta di un vino qualsiasi – dove qualsiasi non significa di basso prezzo ma di scarso valore – ma vuole di più: come nei vini così nei ristoranti, nel cibo, nelle cose da vedere.
Il luogo dà la prima scrematura. Il produttore con la sua etica la seconda: anche lui contribuisce alla forma dell’ospite, attira ciò che è lui (o lei). Questo per dire che se fossi un produttore selezionerei attentamente il luogo in base ai miei valori e non all’afflusso di (im)probabili consumatori, perché, se la mia proposta ha un’etica di fondo, il cliente che si fidelizza è su quella frequenza, non è il beone che si avvicina al mio banchetto e “trangugia” per poi andarsene senza neanche prendere il mio bigliettino da visita o la brochure – tanto ha raggiunto lo scopo: come un primitivo ha trangugiato.

(Un momento della degustazione alle Artificerie Almagià)
Ho anche sviluppato la convinzione che una brutta persona non può fare vini buoni e che i vini sono addirittura frutto di un’educazione, di un approccio gentile e rispettoso verso gli altri prima che verso la natura, dietro la quale molte “filosofie” aziendali spesso si mascherano. Voi vi fidereste a bere il vino di una persona che sapete essere un truffatore seriale? Io no, perché prima o poi trufferà anche me consumatore, o forse lo sta già facendo. Solo chi ha rispetto per il prossimo può avere rispetto vero (e non solo dichiarato) per la natura, l’ecosistema, la biodiversità, e se ne prende cura. Questo perché l’uomo non è progettato a compartimenti stagni. Ritengo che il vino da scegliere sia il risultato di queste dinamiche interiori dell’essere umano, che una degustazione tecnica debba lasciare il giusto spazio anche ad altre considerazioni, a mio giudizio molto più importanti di punti di ph, acidità e simili. Inoltre, un grande vino, a mio avviso, è quel vino che ti fa star bene con te stesso regalandoti la piacevolezza del momento con le persone e il luogo con cui ti stai relazionando.

(Basilica di San Vitale, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco)
A Ravenna, città Unesco e di Byron, anche i ristoratori presenti alle Artificerie Almagià cercavano qualcosa in più: il loro era un approccio filosofico culturale esistenziale. Così le osterie, dove la parola “osteria” sa di nobiltà, di materie prime di eccellenza, basti pensare all’Osteria della Zabariona di Andrea Rondinelli, di fronte al complesso di San Vitale, dove gli ingredienti sono il frutto di una scrupolosa ricerca nella storia della Romagna, vini in primis.

(Taverna Byron, Palazzo Guiccioli)
Così i gestori della Taverna Byron, aperta due settimane dopo il nuovo polo museale, nelle cantine di Palazzo Guiccioli dove visse per due anni Byron, dal 1819 al 1821. La loro è una cucina della tradizione – con piatti prettamente di terra anche se Ravenna affacciava sul mare – dove il cappelletto al ragù è fatto come Dio comanda. E Bianca Scudellari te lo serve con un Sangiovese che sa di Romagna, i cui vigneti si nutrono di bosco, fiume e aria pulita, e questo te lo racconta e te lo fa vivere, mentre Massimo Serena Monghini ti fa capire la sua idea di cucina che ruota intorno al concetto di equilibrio, <<quell’equilibrio nel rapporto uomo-carne che si è perso con l’industrializzazione, con gli allevamenti intensivi che non danno dignità agli animali e che si portano dietro le coltivazioni intensive, come la soia del Brasile causa di disboscamenti allucinanti in Amazzonia, di cui, quando la troviamo nel piatto, dobbiamo essere consapevoli>>. Ecco, quando ti siedi qui non sei semplicemente in un ristorante, sei in un luogo dove si fa cultura non meno che alla presentazione di un libro.
Massimo ci spiega la sua idea di vino perché il vino in tavola parla, in un certo qual modo, anche di lui: <<Brisighella, a 400 metri di altitudine, sulla dorsale appenninica, al confine con la Toscana ma in provincia di Ravenna, per me è il cru bianco della Romagna, anche se lì si possono trovare rossi importanti. I bianchi di quel territorio hanno qualcosa in più perché c’è la vena del gesso che dà spinta e profondità e una parte salina e minerale spiccata, c’è anche uno scheletro marnoso, marne azzurre e arenarie, e i terreni sono molto calcarei. Per questi motivi vengono fuori grandi bianchi sia nella zona del gesso sia in quella marnosa arenacea. Valpiana, dove hanno i terreni Stefano Bariani di Fondo San Giuseppe e Paolo Babini di Vigne dei Boschi per intenderci, è il cru dei bianchi. Bosco e biodiversità sono fondamentali per avere certi sapori nel vino, per la freschezza, per sentire la vibrazione del vivente anche nel frutto che si va a vinificare. Così come trovo importante il progetto Brix, che definisce, valorizzandola, un nuovo stile dell’Albana in purezza – Albana Brix che l’estate scorsa in alcune degustazioni ha retto molto bene il confronto con alcuni Chenin Blanc della Loira -. L’Albana ha una parte tannica e una grassa importanti: è un fuoriclasse di spiccata acidità, quindi è fondamentale il taglio che gli dà il vignaiolo>>.
Stefano Bariani di Fondo San Giuseppe, che raggiungiamo al banco degustazione nel pomeriggio, commenta: <<La tentazione generalizzata è di seguire le mode. Se vanno i macerati, tutti a macerare, ad esempio. Ma non funziona così: non si può macerare tutto. Un produttore intelligente sa capire il suo terroir e interpretarlo bene, ovviamente chi è nelle zone argillose non può che esaltare l’opulenza dell’Albana, chi è in altitudine, come me, l’eleganza>>.

(In foto, lo spaghettone gourmet dell’Alexander)
Fra i banchi dei produttori incontriamo anche Pia Casu, responsabile della carta vini e titolare con il marito Sante Milandri dell’Alexander, nel centro storico, alle vecchie mura di Ravenna, cinema fino al 2002, quando cambia destinazione e diventa un ristorante in cui si sprigiona il talento dello chef Mattia Borroni, classe ’90, che qui lavora dall’età di 19 anni. Impeccabile il menu degustazione. Pia, che fa sempre un passo indietro con la voglia di lasciarsi guidare e in un’altra vita era una talentosa arredatrice d’interni, ha origini sarde, è gentile e garbata e mi parla a lungo di Mattia, che in cucina ha carta bianca, del suo stare sempre al lavoro, dietro le quinte ma protagonista nel piatto, ad imparare, sperimentare tempi, cotture, materie prime. Mattia è ispirato e sogna la stella con la sua cucina identitaria e innovativa, <<legata al territorio ma senza seguirlo per forza>>, spiega lo chef milanese, cresciuto con i nonni materni nelle Marche. Combina al massimo tre ingredienti. Il suo asso nella manica? Un superbo spaghettone trafilato con sugo di peperone arrostito, bottarga di tonno e olive. Ma notevole è anche il piccione <<lasciato una decina di giorni sotto cera, con burro di cacao, per fargli perdere la parte più sanguinolenta e prendere consistenza al morso, poi rosolato in padella e fatto riposare, gustoso con una marmellata di cipolla rossa saltata con radicchio tardivo e aceto e servita con un fondo di cottura dove aggiungo il Madeira per creare un filo di dolcezza>>.

(Menta e Rosmarino, Modigliana)
E i vini degustati mi direte? Ho trovato fondamentale fare questa lunga premessa che fa capire che i vini dei più o meno trenta vignaioli presenti nella zona della darsena di Ravenna, in un luogo trasformato in sala polifunzionale per spettacoli e piccolo teatro, un tempo magazzino per lo zolfo, non sono altro che un’estensione nel calice di questo mood che si respira in città. Da Fondo San Giuseppe, con i suoi 5 ettari di vigneto e 11 di bosco – che ci dice molto di quanto il saper fare artigianale prevalga sulle logiche commerciali -, con la sua Albana elegantissima che al sorso ci fa sentire magrezza, sapidità, salinità nella freschezza, un’interprete davvero sublime del suo terroir, la sottozona Valpiana – che se nell’annata 2023 si è fatta attendere, nella 2024 già rivela il suo carattere e potenziale -, al Trebbiano un po’ fuori dagli schemi di Menta e Rosmarino, della vale Acerreta, a Modigliana, tagliente, minerale, che sa di erbe officinali e al palato regala una certa pienezza e allungo gustativo. La semplicità non è banale nella Nosiola dei terreni marnosi di Pressano, zona storica di produzione, di Maso Grener, altro artigiano meraviglioso, che ci regala un’espressione sottile e fragrante, di buona freschezza, ma anche un Sauvignon che sprigiona tutto il profumo della montagna nella sua persistenza. Chi ama i vini macerati trova in Sosol, di Oslavia, un buon punto di riferimento con il Borjac, da ribolla gialla, malvasia, friulano, chardonnay, e con il Pinot Grigio Ramato Bakren – forse in blend con altre uve –, di ottima acidità a sostenere il frutto e con una vena agrumata che esalta i profumi. Da monitorare per il futuro anche Tenute Tozzi, lungo la vena del gesso romagnola, che mi hanno convita non solo con la loro Albana gastronomica, ma anche con l’Incrocio Manzoni in purezza, alla sua seconda annata, dalla beva piacevole. Mi spiace non essere riuscita a degustare il Cerasuolo, da uve Montepulciano, di Rabottini, prima cantina in Abruzzo realizzata in legno, con vigneti fra le colline teatine, che ha raccolto commenti più che positivi, impressionando i tanti giovani presenti per non essere il solito vino estivo da consumo immediato, ma un vino in grado di raccontare la storia del territorio e della gente che ha alle spalle.

(Rabottini Vini e Oli, Chieti)
Conclusioni finali: l’evento è perfettamente riuscito perché ha posizionato il vino al centro di un progetto culturale più ampio, in cui ogni elemento ha saputo “far squadra”. Alzandone la percezione.