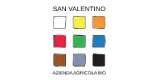Nel paesaggio viticolo del Nord-Est, dove le montagne si incontrano con la pianura e il vento del Garda dialoga con quello delle Alpi, la voce di Albino Armani si distingue per limpidezza e autorevolezza. È una voce che nasce da un legame profondo con la terra: Armani è nato a Dolcè, nella bassa Vallagarina, ai piedi del Monte Baldo, e da lì ha costruito un percorso che unisce esperienza, cultura contadina e visione contemporanea.
Le sue aziende si estendono tra Borghetto d’Avio e Dolcè in Trentino, Marano di Valpolicella in Veneto e Sequals nelle Grave del Friuli. È un uomo di confine, nel senso più nobile del termine: sa abitare i margini con visione, li ascolta e li coltiva. Con lui parliamo di viticoltura d’alta quota, di identità e cambiamento climatico, ma anche del rispetto per quei territori di montagna che chiedono equilibrio e misura.

In Veneto, Trentino e Friuli si moltiplicano tavoli e progetti sulla viticoltura di montagna. Li considera un segnale positivo?
Penso che questi tavoli rappresentino un segnale importante: mettono finalmente insieme agronomi, istituzioni e produttori, cosa che fino a pochi anni fa non accadeva con questa frequenza. Finora era compito dei singoli imprenditori affrontare da soli queste sfide.
Come si può renderli davvero utili e concreti, evitando che restino solo teoria?
Bisogna occuparsi della sostenibilità ambientale ma anche di quella sociale: non si tratta solo di viticoltura, ma di coinvolgere l’intera comunità, come si sta provando a fare sul Monte Baldo, che deve diventare un modello. Nel convegno di Brentonico dell’11 ottobre 2024, promosso dalla nostra azienda, si è discusso in modo critico di cosa può accadere con il cambiamento climatico nelle zone montane. È un tema più ampio delle semplici preoccupazioni locali, perché mette in discussione un equilibrio fragile. Il cosiddetto “modello Brentonico” va preso come riferimento, anche se comprenderne tutte le implicazioni genererà inevitabilmente qualche crepa. Dobbiamo porci delle domande preliminari: è corretto limitare la viticoltura in quota che avanza? E, se sì, con quali strumenti urbanistici? Non si può lasciare tutto al caso. Normare questo sviluppo è un atto politico che va oltre la viticoltura stessa. Se entri in casa d’altri, devi bussare alla porta. Le comunità montane hanno una loro dignità: non è solo chi ha più risorse che può arrivare e acquistare vigneti. La montagna richiede preparazione, consapevolezza e rispetto del limite.
E oggi, secondo lei, questi tavoli stanno davvero producendo risultati?
Il rischio è che restino più dibattiti che azione. Serve una regia comune tra regioni e università per trasformare analisi e presentazioni in protocolli condivisi, accessibili anche alle aziende più piccole. Nella mia esperienza, questi tavoli diventano davvero utili solo quando producono risultati concreti: sperimentazioni in campo, monitoraggi climatici coordinati, linee guida su vitigni e portinnesti resistenti, incentivi mirati all’irrigazione sostenibile, strumenti calibrati sul territorio. Prima, però, si stabilisce dove e come è opportuna la viticoltura, poi si costruisce tutto il resto. Il Trentino e parte del Veneto stanno facendo passi avanti, ma serve velocità: il clima non aspetta le nostre delibere. E infine c’è un altro punto imprescindibile: occorre ascoltare di più chi la vigna la vive ogni giorno. I produttori non devono semplicemente ricevere indicazioni tecniche, ma essere parte attiva della progettazione. Solo così questi tavoli potranno diventare il motore di un vero adattamento e non restare una vetrina di buone intenzioni.
Lei coltiva vigneti in tre regioni. Come descriverebbe oggi la viticoltura d’alta quota nel Nord-Est?
Io ho sempre investito quasi esclusivamente nell’arco alpino, essendoci nato, anche quando non era di moda. Amo la montagna. La viticoltura in quota è sempre stata vista come un disvalore, ma ora questa visione sta cambiando. Solo che coltivare in montagna non è per tutti. I territori fragili hanno bisogno di rispetto e di un racconto diverso. Negli ultimi dieci anni le finestre di maturazione si sono spostate, la variabilità climatica è crescente: estati più calde, segnate però da picchi termici estremi e periodi di siccità prolungata, rendono sempre più complesso il controllo dell’acidità e della maturazione fenolica. L’alta quota rappresenta una risorsa, per preservare freschezza e integrità aromatica, ma oggi più che mai anche una sfida, perché sui pendii più elevati le gelate tardive restano un pericolo concreto. La ricerca universitaria conferma che l’alternanza di stress termici e idrici si sta facendo sempre più marcata anche nel Nord-est, richiedendo approcci agronomici mirati e adattivi, un tempo necessari soltanto nelle regioni del centro-Sud. E soprattutto dobbiamo ripensare le nostre politiche urbanistiche. Salire in quota non basta: se vi si avventurano viticoltori privi di cultura montana, il risultato è destinato a fallire. Serve ascolto, quello autentico di chi la montagna la vive, un atteggiamento oggi tutt’altro che scontato.
Quali pratiche agronomiche adottate nei vigneti d’alta quota per coniugare equilibrio ambientale e qualità produttiva?
Nei nostri vigneti non interveniamo sul substrato pedologico: la vite si appoggia sul terreno antico, senza scassi né arature profonde che potrebbero alterare la stabilità del suolo e favorire fenomeni di erosione o frane. È una scelta di rispetto, che implica accettare rese più basse ma coerenti con una vera sostenibilità. Collaboriamo inoltre con gli allevatori: lo scambio di sostanza organica diventa un circolo virtuoso, un modo per restituire vita e fertilità al terreno. Le cover crops sono fondamentali per trattenere l’acqua, ma prioritariamente dobbiamo preservare le linee di livello e consolidare la struttura del suolo. Studiamo con attenzione i sistemi di allevamento tradizionali, adattandoli al presente, e preferiamo potature e diradi misurati, perché la montagna richiede equilibrio più che forza.
Con la “Conservatoria” lei lavora sul recupero di vitigni antichi. Possono essere una risorsa contro il cambiamento climatico?
Sì. Stiamo riportando vitigni come la Nera dei Baisi nella sua area d’origine, a Terragnolo, sulla sponda sinistra dell’Adige. A Borghetto abbiamo viti ultracentenarie di Foja Frastagliata, con un DNA unico da studiare. Il grande lavoro sul Foja Tonda non è solo nostalgico ma dinamico: cerchiamo di capire plasticità fenotipica, maturazione e resistenza. In certi contesti, cultivar locali possono offrire maggiore stabilità qualitativa sotto stress, oppure permettere vini con profili più autentici e strutturati, pur mantenendo rese sostenibili.
C’è chi propone di introdurre varietà mediterranee più produttive. È una soluzione valida?
Prima di importare modelli esterni che non sono in equilibrio con il territorio, bisogna capire perché vitigni acclimatati da secoli possono resistere cento anni e oltre, e anche loro subiscono il cambiamento climatico. La resilienza economica del territorio passa dalla sua identità. Ogni scelta va fatta partendo da ciò che già abbiamo.
Le istituzioni regionali stanno facendo abbastanza per sostenere la viticoltura d’alta quota?
Ci sono iniziative e fondi, ma manca coordinamento. La frammentazione amministrativa rallenta tutto. Servono sinergie tra regioni e università per trasformare la ricerca in pratiche concrete: irrigazione innovativa, studi clonali, piani antibrina. E servono piani assicurativi contro il cambiamento climatico.
Collaborate con università e centri di ricerca?
Sì. Lavoriamo con la Fondazione Edmund Mach, fondamentale per studiare la fisiologia della vite in quota e gli indicatori di stress. Serve una filiera che unisca sperimentazione, genetica e trasferimento tecnico agli agricoltori ma anche a chi decide i piani regolatori. Serve uno studio propedeutico per capire dove e come si può coltivare.
Vale la pena investire nei vitigni antichi o nei nuovi cloni?
In entrambi. Le vecchie varietà contengono geni di resistenza che possiamo trasferire ai nuovi cloni. Sto finanziando la ricerca sui portainnesti “M”, una serie di portainnesti di ultima generazione che nascono da un programma di ricerca coordinato dal professor Attilio Scienza, insieme a un team del Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano – oggi CREA-VE – e dell’Università di Milano. Non sono contrario alla cisgenetica: l’importante è capire e valorizzare ciò che la natura ci ha già dato. I vitigni antichi custodiscono una variabilità adattiva di grande valore. Oggi, grazie alla clonazione e alla selezione mirata, possiamo individuare e moltiplicare biotipi capaci di rispondere meglio agli stress idrici e termici. Con la Conservatoria cerchiamo di coniugare la tutela del patrimonio genetico con la valorizzazione agronomica, promuovendo programmi clonali che uniscono qualità, identità e resilienza.
Come il riscaldamento cambierà i vini del Nord-Est e lo stile Armani?
Avremo maturazioni più rapide e vini più ricchi. Ma io voglio mantenere acidità e bevibilità: concentrazione sì, ma senza perdere eleganza. Non inseguo il calore, voglio preservare freschezza e identità.
Le tecnologie aiutano davvero ad adattarsi al clima?
Sì, ma sono costose. I sensori, i modelli climatici e l’irrigazione di precisione sono strumenti potenti, ma difficili da adottare per i piccoli produttori. Servono reti di servizio e incentivi pubblici, oltre al trasferimento tecnologico universitario.
Il mercato del vino premia la resilienza?
Sempre meno: vincono le cose facili, i vitigni modaioli. Ma forse i consumatori più giovani saranno più attenti all’origine, alla storia, alla sostenibilità. I vini che raccontano un territorio trovano spazio se c’è comunicazione e consapevolezza. Il problema è la transizione economica: occorrono misure che compensino le rese più basse e i costi di pratiche sostenibili. In certe zone la redditività è troppo bassa. I costi aumentano, i vini calano di prezzo. Va ripensato anche il limite dell’1-2% annuo di superficie vitata concessa: dobbiamo discuterne.
Se dovesse lasciare un consiglio ai viticoltori del Nord-Est per i prossimi anni?
Resistere. Credere che il cambiamento vada agito dall’interno. Prendere parte ai consorzi, farsi sentire. Alzarsi dalla sedia e pretendere di esserci. Non si tratta di reinventare il vino, ma di adattare il modo di coltivarlo senza perdere identità. Ai giovani dico: indignatevi. Mi sono “tirato fuori” dal Consorzio del Pinot Grigio delle Venezie perché voglio vedere giovani protagonisti. Bisogna crederci. Devono crederci.