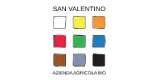La vendemmia 2025 si apre con un filo comune: molte aree hanno anticipato la raccolta e, nonostante le incognite climatiche, le prime impressioni parlano di una qualità buona–ottima. Le stime di Coldiretti collocano la produzione complessiva intorno a 45 milioni di ettolitri, in linea o in lieve crescita rispetto alle annate recenti; ma l’attenzione non è solo ai numeri: è alle strategie che servono a proteggere il valore del vino italiano sul mercato globale. La vendemmia 2025 conferma che il mondo del vino italiano non è solo agricoltura: è governance, saper tecnico e narrazione.
Per gli enologi la parola d’ordine è adattamento. Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, ha invitato a “governare i volumi in modo selettivo” per evitare squilibri che possano deprimere i prezzi e la redditività delle imprese: la gestione della risorsa uva in vigna e delle scelte in cantina (tempi di raccolta, macerazioni, controllo delle temperature) saranno decisive per trasformare l’anticipo climatico in un’opportunità qualitativa.

Fra le regioni, la Sicilia è stata tra le prime a cominciare, con raccolte precoci su Pinot Grigio, Chardonnay e basi spumante e con uno stato sanitario buono e prime sensazioni positive sulla qualità. Nel Nord-Est (Trentino, Alto Adige, Friuli) raccolte anticipate, buono l’equilibrio zuccheri-acidità e ottimo stato sanitario in molte aree. In Franciacorta avvii regolari e attese positive per qualità delle basi. Nel Centro (Toscana, Umbria, Marche) uve sane in molte zone, con le rese che variano localmente ma la qualità è promettente. Il Sud è in ripresa rispetto al 2024, ma alcune aree restano sotto stress idrico.
Per quanto riguarda il nodo delle giacenze e la politica dei consorzi, il tema economico che fa da sfondo è noto: giacenze elevate in alcuni territori e consumi mondiali sotto pressione rendono necessarie misure di governo dell’offerta. In questo senso molti consorzi e DOC hanno scelto strumenti pragmatici: riduzione delle rese, stoccaggio amministrativo, normative temporanee per proteggere la valorizzazione del prodotto.
Per il Pinot Grigio DOC Delle Venezie la stagione 2025 vede misure chiare: resa massima ridotta da 180 a 170 q/ha e possibilità di stoccare fino a 20 q/ha come misura per stabilizzare il mercato e calmierare l’offerta. È una strategia di tutela del valore che mette in luce la volontà dei consorzi di agire sul controllo delle quantità. Il Veneto è luogo di contrappesi: grande produzione, forte export, ma anche vulnerabilità ai cambiamenti nei flussi commerciali internazionali (dazi, sanzioni) e a fenomeni climatici locali. In Valpolicella il Consorzio ha approvato una misura netta: limite a 100 quintali per ettaro per i prossimi tre anni, scelta motivata dalla necessità di garantire sostenibilità socio-economica alle imprese e limitare gli squilibri di mercato. Il provvedimento è stato formalizzato anche in atti regionali. Una misura esemplare: non si tratta di rincorrere una logica ideologica contro la quantità, ma di difendere valore e identità territoriale in un contesto in cui l’aumento dell’offerta non sempre corrisponde a domanda remunerativa — anzi, può spingere verso una spirale di abbassamento dei prezzi che danneggia i produttori. Al contempo il Veneto continua a investire in promozione e strategie di mercato per valorizzare stili e denominazioni.
Secondo il presidente del Consorzio Valpolicella Christian Marchesini, “difendere la sostenibilità economica della filiera significa governare l’offerta, in un momento in cui il mercato chiede sempre più selezione”. In pratica, ridurre le rese mira a preservare il valore dei vini, garantendo una redditività migliore per viticoltori e cantine. Allo stesso tempo, si potenzieranno le attività promozionali, in Italia e sui mercati esteri, puntando su vini freschi, più leggeri e serviti a basse temperature.

Cosa significa questo in cantina e per il consumatore? Per i produttori: più attenzione alla scelta del momento di raccolta, maggiore precisione nelle pratiche enologiche (controllo delle temperature, macerazioni regolate, uso selettivo di tecnologie di stabilizzazione e affinamento). Per il mercato: una tendenza verso vini più freschi e beverini in alcune categorie (bianchi e rosati), mentre i grandi rossi continueranno a puntare su struttura e territorialità. I consumatori vedranno una proposta più calibrata e — auspicabilmente — meno soggetta a sconti eccessivi che deprimono la percezione di valore. I rischi non mancano. Le ondate di calore tardive e la siccità, che in alcune zone del Paese hanno già messo alla prova i vigneti, restano una minaccia concreta. A questi si aggiungono fattori esterni, come la pressione dei dazi e le incertezze geopolitiche, che possono comprimere l’export in mercati chiave. In questo scenario, la semplice abbondanza non è più garanzia di successo: produrre di più può diventare un boomerang.
Eppure, proprio dalle difficoltà emergono nuove opportunità. La riduzione volontaria delle rese, come sta accadendo in Veneto con la Valpolicella e nella DOC delle Venezie, non è solo una misura tecnica, ma un vero e proprio cambio di paradigma: governare l’offerta per proteggere il valore. È una scelta che privilegia la qualità alla quantità, che rafforza l’identità territoriale e che guarda a un mercato più selettivo e consapevole.
Accanto a questa governance più rigorosa, il settore sta scoprendo strade innovative: turismo enogastronomico, esperienze immersive nei territori, diversificazione dei mercati di sbocco. L’Italia del vino non si limita a difendersi, ma prova a trasformare ogni sfida in un’occasione di racconto e di crescita. Così la vendemmia 2025, pur segnata da rischi climatici ed economici, diventa il simbolo di un settore che non arretra. Anzi, rilancia: meno bottiglie, ma migliori; meno numeri, più storie da raccontare. E in questo equilibrio tra tradizione e strategia, tra fragilità e resilienza, il vino italiano conferma la sua capacità di guardare al futuro con coraggio e con orgoglio.